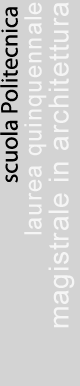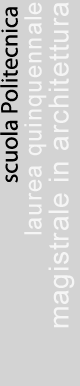 |
| Laboratorio di Progettazione I E |
codice corso 14203
|
Laboratorio - 180 ore - 10 crediti formativi universitari
- Insegnamento caratterizzante
ICAR/14 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA - 120 ore
Simona Gabrielli
|
codice corso 14204 |
- Modulo A
ICAR/12 - TECNOLOGIA E PROGETTO - 60 ore
Rossana Raiteri
|
codice corso 30282 |
Il corso è articolato in due parti.
Una parte di lezioni teoriche attinenti strumenti, metodi ed elementi della composizione architettonica, con particolare attenzione alle problematiche legate al tema del rapporto con la preesistenza.
Una seconda parte di lavoro di laboratorio articolato in tre esercitazioni progettuali individuali di elaborazione e verifica dei temi affrontati nelle lezioni.
Ad ognuna delle tre esercitazioni progettuali corrisponderà lo stato di avanzamento di una personale ricerca scritta e documentata attraverso riproduzione di disegni e immagini sugli elementi della composizione architettonica, secondo alcuni parametri indicati.
Il lavoro viene seguito e verificato attraverso revisioni settimanali.
Sono previste tre consegne a cadenze prefissate con una presentazione pubblica da parte dello studente, l’ultima delle quali consisterà nell’esame finale ove verrà presentato il lavoro di tutto l’anno nel suo complesso e un breve colloquio sui testi consigliati in bibliografia.
Lezioni
Il corso teorico si articola attraverso tre tipologie di lezioni sui temi della composizione architettonica con attenzione ai problemi della preesistenza.
Inoltre è prevista un’altra serie di lezioni ad invito di docenti esterni al corso che aprano ad una visione trasversale fuori campo rispetto ai temi della progettazione architettonica.
a. Elementi di composizione architettonica
- Processo progettuale. Questioni di metodo
- Elementi della composizione architettonica
- Tettonica/Topografie operative
- Luogo/contesto/paesaggio
- Vincoli. Il ruolo della preesistenza
- Programma funzionale
- Significato dell’uso dei materiali della costruzione
- Scala/misura/proporzione/geometria/modulo
- Strumenti di controllo del progetto
- Contenuti del progetto/rappresentazione
b. La storia “presa a prestito”
- Costanti tra architettura del passato, del moderno e del contemporaneo attraverso la lettura del progetto architettonico
- Il rapporto con la storia. Questioni di linguaggio architettonico
- Architettura giapponese. Il rapporto con il tempo
c. Il progetto e la preesistenza
- Albini a Genova. Il museo del Tesoro di S.Lorenzo e il museo di Palazzo Rosso
- Carlo Scarpa. Il museo di Castelvecchio a Verona e la Fondazione Querini Stampalia a Venezia
- Francesco Venezia. Il museo di Gibellina e il teatrino di Salemi
- Norman Foster. La Maison Carrée a Nimes
Esercitazioni progettuali
Il corso affronta tre temi di composizione architettonica tra loro connessi, concepiti come momenti di un processo progettuale a diversi livelli e che, alla fine, vanno a costruire un unico tema di progetto. Tale approccio permette di avere tre diverse esperienze progettuali e contemporaneamente di declinare gradualmente i passaggi che scandiscono il processo compositivo. L’idea che poi vadano a comporre un unico progetto finale permette una continua correzione di tiro rispetto agli obbiettivi e la possibilità di ricalibrare ed affinare le soluzioni attraverso la logica del procedimento ermeneutico.
I diversi temi lavorano sugli elementi compositivi elementari facendo entrare in gioco il vincolo del rapporto con la preesistenza.
L’elemento preesistente è un vecchio muro ligure a secco (di una creuza, un muro spartivento di crinale) rispetto al quale si articolano le tre esercitazioni compositive.
Prima azione bucare il muro per andare aldilà (quale bucatura, interno-esterno, soglia, percezione). Seconda azione fiancheggiare il muro per raggiungere una meta. Il percorso.
Terza azione la meta diviene costruzione di un involucro.
Vocabolario di elementi della composizione
Molte parole che attengono strettamente al campo disciplinare della progettazione architettonica sono spesso utilizzate impropriamente o superficialmente poiché spesso non ci si sofferma sul loro significato originario o sulle sua evoluzioni in significati sempre più articolati e al tempo stesso incerti ed ambigui. Questa è una delle ragioni delle difficoltà incontrate a comprendere il senso del linguaggio ed i concetti propri della materia che si indaga. Ma è anche fonte della diffusa tentazione di utilizzare l'equivocità dei termini come strumento di mistificazione ideologica e progettuale.
Ne deriva l'esigenza di un’introduzione rapida ai contenuti della disciplina senza rinunciare al rigore scientifico degli enunciati con l’obbiettivo di arrivare conoscere e riconoscere gli elementi della composizione architettonica per poterli nominare correttamente.
Ogni studente svolgerà una ricerca individuale sulla definizione argomentata di uno dei termini del vocabolario e una catalogazione ragionata di diverse declinazioni possibili di quell’elemento architettonico all’interno del percorso progettuale di una delle figure di architetti del moderno o del contemporaneo.
| Bucature Finestra Porta |
Le Corbusier, Steven Holl, James Stirling, Alvaro Siza, Giuseppe Terragni |
| Muri setti |
Ludwig Mies Van Der Rohe, Alvar Aalto, Luis Barragan, Peter Einsenman |
| Struttura/involucro |
Le Corbusier, Jacques Herzog Pierre De Meuron, Jean Nouvel, Peter Zumthor, Louis I.Kahn, Frank O.Gehry, Oswald M.Ungers |
| Pianta libera |
Le Corbusier, Ludwig Mies Van Der Rohe, Rem Koolhaas, Peter Einsenman |
Copertura
(tettoia, piana, a falda, volte)
|
Eero Saarineen, Louis I.Kahn, Mies Van Der Rohe, Frank L.Wright |
Percorso
(corridoio - promenade architectural)
|
Le Corbusier, Tadao Ando, Frank L.Wright, James Stirling |
| Pilastro/Colonna |
Le Corbusier, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Aldo Rossi |
| Scala/rampa |
Le Corbusier, Franco Albini, Norman Foster, Adalberto Libera |
| Ingresso/soglia |
Carlo Scarpa, Alvaro Siza, Aldo Rossi, Jean Nouvel, |
| arco/trave |
Louis I.Kahn, Aldo Rossi, Le Corbusier |
| rivestimento/pelle |
Jacques Herzog Pierre De Meuron, Jean Nouvel, Frank O.Gehry, Rafael Moneo |
| basamento (rapporto con il suolo) |
Ludwig Mies Van Der Rohe, Jean Nouvel, Aldo Rossi, Carlo Scarpa |
| coronamento (rapporto con il cielo) |
Jean Nouvel, Aldo Rossi, Rafael Moneo |
| angolo/spigolo |
Le Corbusier, Ludwig Mies Van Der Rohe, Peter Eisenman |
| cortile/patio |
Frank L.Wright, Adalberto Libera, Mies Van Der Rohe |
Bibliografia
La lettura integrale di almeno uno dei testi sotto elencati costituisce materiale d’esame. Alcuni brani e passi significativi verranno comunque commentati e distribuiti a lezione durante l’anno insieme ad altri estratti non contenuti in bibliografia.
Le Corbusier, Verso un’architettura, Longanesi, Milano 1984 (1921)
Rossi Aldo, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966
Venturi Robert, Complessità e contraddizioni in architettura, Dedalo, Bari 1980 (1966)
Quaroni Ludovico, Progettare un edificio. Otto lezioni d’architettura, Gangemi, Roma 1993 (1977)
Purini Franco, Comporre l’architettura, Universale Laterza, Bari 2002
O un qualsiasi altro testo scritto da un architetto di cui lo studente motivi la scelta.
|